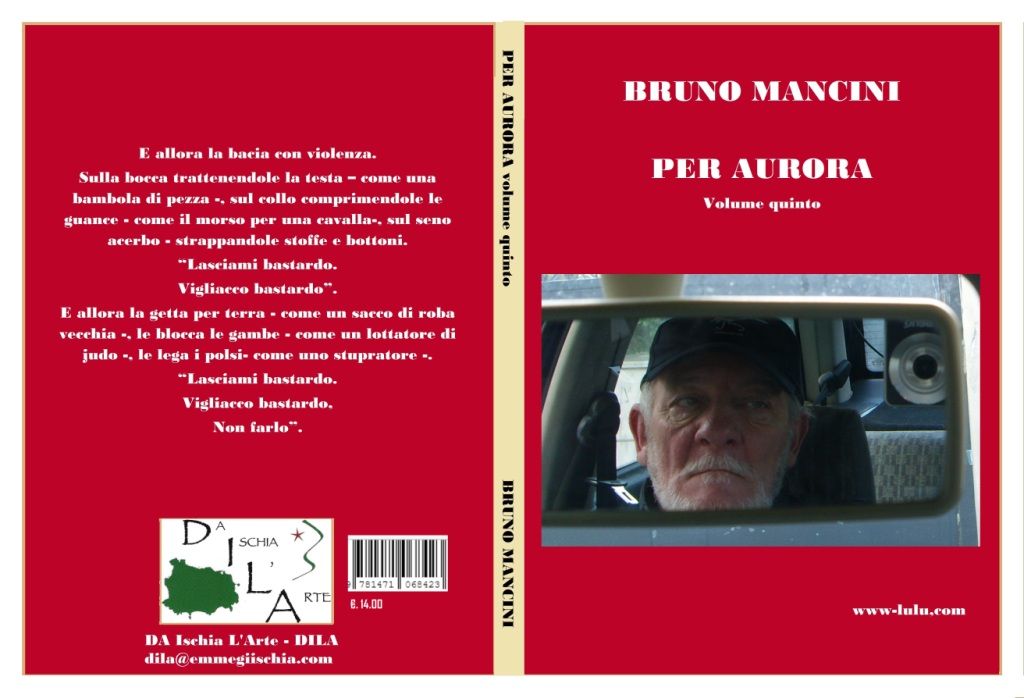
Per Aurora – volume quinto – Così fu PARTE 1 CAPITOLO DODICESIMO
TESTO COMPLETO IN LETTURA LIBERA
Per Aurora – volume quinto – Così fu PARTE 1 CAPITOLO DODICESIMO
CAPITOLO 12
Ho chiesto un taxi.
Ho indicato la meta.
Ho pagato la corsa.
Ho atteso che si allontanasse.
Ho iniziato a muovermi verso la cascina.
La casa, imperturbabile, ha lasciato che mi avvicinassi con incedere inconsueto – deciso, ma lento -, forse curiosa di capire dove si allocassero le mie intenzioni, o forse ormai indifferente a qualunque improbabile tentativo di oltraggio.
Non ho udito scricchiolii di finestre mal chiuse e non mi hanno distratto rami ciondolanti e serpentelli striscianti negli anfratti alla base della muratura.
La casa collaborava a rendere intrigante la mia presa di possesso, e non si prestava a mostrarsi rivestita di misteri o d’imprevisti sulla falsa riga di un’avventura esotica. La casa stava.
Eri io che muovevo passi decisi ed incerti, sicuri e titubanti, attenti e precari, passi di automa mal programmato, di veglia sonnambulica, passi guidati da una ragione extra corporea, indefinita.
Frattanto, forse, Gilda sarebbe apparsa seduta, all’ombra della magnolia che aveva la sua stessa età, sugli scalini arrotondati che segnavano l’ingresso al pergolato di canne e foglie di palme, avvolgendo un bambino in braccio.
Oppure, Gilda sarebbe apparsa poggiata al fusto della magnolia, le mani intrecciate dietro il collo, i gomiti sporgenti verso l’intruso, nell’atto di coprire il suo territorio con la stessa determinazione della belva intorno alla cucciolata.
Avresti potuto offrirle il cinghiale selvatico ucciso a morsi e pugni e lei non avrebbe ceduto un millimetro di spazio ai tuoi tentativi di avvicinamento.
Un cucciolo: Isidoro.
Una zona proibita: la sua vita affettiva.
La sua cantilena: “Il mio piccino non sarà mai solo.
Il mio piccino non sarà mai solo.
Il mio piccino.”
Appena ho superato il cancello a stecche di ferro verticali con residui di vernici verdi e nere, ho provato, calpestando i sassi polverosi del sentiero d’accesso ad un piccolo campo, la sensazione che i miei mocassini firmati Velente avessero immediatamente odiato il titolato negoziante di Via Montepelone per non avere responsabilmente provveduto alla loro collocazione presso una figura umana adeguata, in quanto a stile di vita e classe sociale, alla origine ed al censo dei quali si pregiavano.
Tomaia di cuoio… cuciture con filo… punti a … pelle di… borchia e… vernice… con me nella polvere e nel fango.
Le scarpe con certificati di origine DOC, DOCEC, UE, MADE IN ITALY, a modo loro pensavano che neppure Napoleone Bonaparte, l’uomo delle disfatte ciclopiche, avesse subito simile affronto, e che loro, di certo, non meritavano tale ignominioso sfregio in così tenera età.
Per un attimo, poggiando la mano sul lato sinistro del cancello, nell’atto di agevolarne la chiusura difettosa a causa della ruggine sedimentata tra i mozzi dei cardini, ho avuto la tentazione di scalzarmi e proseguire a piedi nudi.
Per un attimo ho corso il rischio di vanificare fin dall’inizio il progetto amorfo appena cominciato.
Due colonne di tufo verde non intonacato fungevano, una – quella a sinistra entrando – da stabile appiglio verso la parte interna del podere per un sultano roveto dalle more grosse come ciliegie, il quale, a sua volta, consentiva alcuni disagiati inserimenti ad uno striminzito arbusto di capperi attiguo ad un cespuglietto di bocche di leone in piena fioritura, mentre l’altra colonna, quella verso nord, meno esposta alla calura estiva, e situata al riparo dell’ombra di un ficus alto oltre quattro metri e largo fino al successivo angolo del muro di cinta, pareva civettare nel mostrare la pelle rugosa delle sue pietre dai toni cangianti a secondo che variassero le luci e le ombre di contorno.
“Bisognerebbe scrostare le scaglie di vernice dai segmenti verticali del cancello, scartavetrare il disegno composto da semplici volute a forma di spirali che si uniscono tra di loro, e che congiungono le barre di sostegno forgiate a mano, nell’antica eleganza propria dei lavori artigianali, ribattendo il metallo su una vecchia incudine a forma di doppio cono.
Sarebbe urgente completare l’opera di ripristino ridando lustro alle lance infisse in cima alle aste divisorie ove completano la parte superiore della cancellata come una corona di artigli.
Spuntare i rami penduli spinosi che creano intralcio alla chiusura del cancello e costituiscono un pericolo per le pregiate camicie di lino inglese che indosso.
Smussare i bozzi antiestetici scavati nelle pietre dal rivolo non incanalato che cola dalla sommità del pilastro. Bisognerebbe… ma sono pazzo?
Come se la mia presenza non bastasse già a svilire il paziente equilibrio ottenuto da questo lembo, di tempo più che di spazio, incurante delle violenze portate dagli uomini fino intorno ai suoi confini!”
L’aspirazione del pellegrinaggio laico per molti anni dato per scontato dalla nostalgia ma rifiutato dalla suggestione della malinconia, eppure mai prima valutato nelle conseguenze pratiche, rischiava di trovarsi sfaldata al momento dell’iniziale impatto con una realtà, ove i pensieri di abitudini a me comuni mostravano di essere rabberciati ad inconsueti schemi di rivolta.
Sfuggendo al dedalo di considerazioni che imboccavano l’uscio della mia attenzione, ruotando il capo in direzione del viale sommerso sotto erbacce affastellate dai lati verso il centro in un groviglio che a mala pena lasciava scorgere una porzione del tetto con due comignoli a forma di parallelepipedo, ho smesso di porre mente al lavoro manuale che sarebbe occorso per restituire i luoghi alla loro primitiva configurazione, e mi sono avviato, lentamente, verso la ricerca di una mia origine.
“CAPIRE”.
Certo anche nel viaggio mentale bisognava scostare barricate pungenti e resistenti come i roveti insediati dalla natura in maniera disordinata lungo il camminamento che conduceva alla casa, ed occorreva dipanare una immensa ragnatela di labili ricordi e trasparenti indizi agganciandone la scia invisibile con l’attenzione di chi debba razionalizzare il percorso prescelto.
Nel mio seguire un filo di intrecci meno folti, quasi una giungla casereccia, formato in prevalenza da liane di edere mediterranee e felci sovrastanti papaveri all’ombra delle ginestre (ginestra, fiore amato dalla mia donna) non ancora in fiore, la mole simmetrica del fabbricato, con i due balconi del primo piano poco distanti dagli angoli ed il portone di legno massiccio punteggiato all’estremità superiore da una nicchia votiva per un santo protettore, ad ogni passo, mi veniva incontro piano piano mostrando i segmenti di un puzzle che andavano continuamente ad accostarsi fino a formare la visone totale della sua struttura.
Finché, inaspettatamente, le piante e gli arbusti hanno finito di occupare parte del territorio, lasciando una chiazza semi desertica in corrispondenza del cortile antistante l’ingresso.
Un regalo della natura aveva permesso che il tavolo ed i sedili di lastroni lavici sistemati appena accanto al pozzo fossero soltanto ricoperti di muschio e piccoli fiori di campo, mentre, stupendamente incoronato da tralci di vite selvatica, il piano terra si confondeva con l’adiacente boscaglia.
Volevo, potevo, dovevo entrare?
“Che sia più semplice raggiungere una meta che non goderne i privilegi?”
Mancavano molte ore la tramonto, ed io ho avuto voglia di entusiasmarmi per ogni particolare di quel luogo, né brullo né antico, né vivo né solingo, così simile ai contorni che la vita mi offriva nella quotidiana stagnazione di affetti e prospettive di speranze.
Cos’altro erano le mie giornate tra scartoffie, progetti, bolli, scadenze, impegni, indirizzi, ripetitivi incontri, Mario l’usciere, Aniello il barbiere, Giuseppe l’autista, Vincenzo il praticante di studio, Cinzia la segretaria, Anna la collaboratrice domestica, Domenico il giornalaio, Teresinella la barista che mi porgeva il cappuccino al mattino, Rosa la bellina del bar all’ora dell’aperitivo, documenti, appuntamenti, relazioni, accordi, carte e poi di nuovo scartoffie… se non una lunga stagnante riproduzione della natura, ove le ginestre (ginestra, fiore amato dalla mia donna) continuino a fiorire nei periodi previsti, le edere seguitino senza sosta ad arrampicarsi verso i comignoli più alti, ed i papaveri contrastino un posto al sole alle margherite?
A Roma non avrebbe avuto senso che io ragionassi intorno all’ipotesi di potatura del grumo di spine, come non avrei impegnato più di un minuto per decidere se provvedere alla tinteggiatura del cancello ed al ripristino estetico dell’intero perimetro del muro di cinta.
A Roma, nel mio ufficio di Piazza Mergellina, la segretaria Gloria si faceva quotidianamente carico di risolvere ogni minimo dettaglio delle contingenze che mi si presentavano.
Una balia, una balia abruzzese, una balia abruzzese cui affidavo i figli illegittimi dei miei impegni professionali.
Il contatto fisico con la tenacia consistenza delle assi d’ulivo scarnite dalle intemperie e poi increspate per il degrado dell’intero portone, offendeva e sfidava la leziosa morbidezza delle mie mani ben curate e prive di rughe.
Su di esso, fenditure profonde spaziavano in verticale, prevalentemente verso la parte bassa del legno con solchi profondi a forma di cunei e reticolati simili ai rivi della foce di un fiume tra lagune, stagni, e deviazioni per ostacoli formati da sedimenti venuti da lontano.
Intorno alla parte inferiore, principalmente a contatto con il suolo, il marciume dovuto alle pozze di acque stagnanti, ne aveva quasi polverizzato gran parte del bordo orizzontale strutturato come appoggio per le sette assi che componevano ciascun battente.
Non ho smesso di tastare, palpeggiare, annusare, sbirciare, fin quando non mi sono accorto che, dolcemente ma con caparbia determinazione, stavo sbriciolando i bordi consunti scavando nelle tane e tra le larve delle formiche.
Ho sentito, intanto che mi conformavo alle sensazioni tattili, olfattive, visive, prodotte dal connubio che andavo attuando con il luogo nel suo complesso, avanzare dentro di me, ma stranamente ancora più intorno a me, il respiro lento della precedente notte trascorsa tra veglia e sonno.
Una incipiente sensazione di completa immobilità, quasi mi stesse mancando la benzina nel motore e che fosse necessario avviare manualmente il ventilatore affinché rimanesse vivo il mio computer umano.
Molte altre volte al risveglio, in special modo dopo notti turbate da sogni troppo presto risultati evanescenti, mi ero accorto di simili sintomi e li avevo esaminati nel tentativo di poterli dominare, così che sentendoli sopraggiungere, pur nella completa veglia di quei miei primi passi nella cascina, mi sono meravigliato, ma ne ho tratte conclusioni logiche in sintonia con i riscontri oggettivi che mi erano sembrati prevalere nelle precedenti situazioni.
Accadeva che nessuna forzature riuscisse s muovermi.
Per ogni completo risveglio dovevo necessariamente attendere quei pochi o molti minuti necessari ad umettare le labbra, stropicciare gli occhi, stendere le braccia, contrarre le dita dei piedi, respirare profondamente, sbadigliare rumorosamente, emettere una serie di colpetti di tosse, usare la mano come sipario scivolante dagli occhi al mento.
A volte avevo tentato di rifiutare questo rito pagano al dio risveglio nei modi più semplici, ed anche nelle maniere più astruse, rincoglionendomi intorno ad una sciarada che avrei voluto comporre con differenti soluzioni, raccogliendo però quasi sempre deludenti sconfitte.
Infatti, quando con impegno riuscivo a sbloccare la distensione delle braccia, di conseguenza, accumulavo piccoli rapidi movimenti delle spalle, e se pervenivo con successo ad impedire volutamente uno dei colpetti di tosse, allora una serie sorda e strozzata di mugugni mi saliva e scendeva dalla faringe allo stomaco.
Niente da fare.
Con semplicità non ero mai riuscito a risolvere il caso.
Se non cessava il respiro lento non iniziavo la marcia.
Non si attivavano le pattuglie di avanguardie preposte alla salvaguardia dei percorsi da delineare come struttura per il mio nuovo giorno.
Un mattino tentai una nuova soluzione temeraria.
Gilda.
Gilda tra le mie braccia come non era mai stata riversa in mezzo ai fior” – diceva Quasimodo -, mi supera la luce e tocca le tue braccia ignude – diceva Quasimodo-, all’amata che in se agita un mio figlio – diceva Quasimodo.
Con un movimento rapido, inatteso, ma per niente incoerente, invece di alzarmi e correre incontro al sogno, misi la testa sotto il cuscino per non rischiare di perdere un solo lembo d’immagine altrimenti sfocato dalla luce penetrata attraverso le giunture sconnesse della finestra, per non disperdere una sola briciola del suo odore di muschio e di ginestre (ginestre, fiore amato dalla mia donna) nel turbinio di effluvi di caffè e di fette biscottate che mi giungevano diffondendosi dalla cucina, per non dimenticare il null’altro importa che volevo rinchiudere in un profondo ed inaccessibile, anche a me stesso, scrigno di difesa.
Invece di schizzare dal letto ed andarla a cercare, sentii girarmi la testa, le palpebre pesanti, il suono di una nota alta di clarino tenuta continua come un fischio di richiamo, le mani gelate, il cuore fermo e Gilda che rideva, tra le mie braccia, con il volto ondulato dai frammenti di luce filtrati tra le foglie della magnolia, e rideva e rideva, tra le mie braccia, con il corpo adagiato in un groppo di papaveri e bacche di mirtilli, profumata di muschio e di ginestre e papaveri e mirtilli e gioia, come non aveva mai fatto.
In verità, fin dall’infanzia, i nostri destini parevano inseparabili, simili ai pali infissi nella laguna veneziana che delineano il tragitto dei vaporetti di linea.
Allineati verso una identica lontana meta ma distanti quanto basta per essere continuamente divisi non soltanto dallo spazio fisico ma finanche, peggio, dal rumore disordinato dei pendolari e dei vacanzieri che percorrono quella tratta, dagli sbuffi di nafta soffiati dalle ciminiere dei battelli, dal moto ondoso provocato dalle eliche in continuo passaggio.
Con una iperbole fantastica, in età successive, avremmo potuto credere che le finestre delle nostre stanza si confrontassero chiedendosi: Era lui?, Era lei?, Si è già affacciato?, Dorme?, Studia?, C’è la Signora?, Aspetta?, Aspetta!, intanto che catturare con uno sguardo il suo finto innaffiare il vaso di gerani alla finestra mi bastava per avere la speranza d’incontrarla più tardi, forse, chi sa, all’angolo del viale tra la locanda e il ciabattino, durante il suo ritorno a casa dalla vicina merceria.
Quasi come per caso, nonostante avessi levigato quel tratto di strada con un continuo insignificante via vai.
Gilda?
Gilda?
Avrebbe riprodotto il mio volto ad occhi chiusi, disegnato le mie mani senza il minimo errore, riconosciuta la mia sagoma anche di profilo, anche di spalle, con la certezza di un istinto ancestrale.
Avrebbe voluto il mio amore con la passione di una vergine fanciulla incantata da un sentimento sconosciuto ed invadente.
Due pali nella laguna che niente e nessuno univa, e che da soli non trovavano il sistema di accostarsi, nonostante fossero, nei sogni e nei pensieri, nei sogni e nei pensieri, comunque, nei sogni e nei pensieri, sempre, propensi, determinati, decisi, oltre ogni altra volontà, e desiderosi di sradicarsi per galleggiare uniti. Invidiosi dei colombi che tubavano sulle loro sommità.
Durante la nostra gioventù, le mattinate sembravano passare con le monotonie visive e le staticità fisiche di un impianto scenico ove le luci e i colori e le forme e le dimensioni siano trattenute nella loro originaria bellezza dalla forza del tempo che le gestisce.
Le notti scorrevano in un turbinio di sopraffazioni, intrecci, incastri, smosse e confuse per minuscoli dettagli ed enormi visioni.
“Aveva girato lo sguardo verso il gatto randagio che attraversava la via oppure… oppure… oppure mi aveva guardato?”
” Non sono io la preda da conquistare!”
“La preda?”
“Lei non sarà mai una preda.”
“Gilda io l’amo.”
Neppure il tempo di soffermarmi sulla parte logica di queste questioni ed ecco le notti, sempre, apparire immobili contro la violenza di urla disperate, secche e ripetitive, come accordi iniziali della quinta sinfonia: papapapà – pàpapapa.
Vieni da me!
Vieni da me.
Il gallo taceva sbalordito, le campane non colpivano i batacchi, il pullman di linea s’inerpicava su tornanti dall’acustica frammentata, gli anziani vicini di casa – di notte svegli da sempre – misuravano la potenza ed il timbro per elaborare
una proiezione e prevedere un nostro futuro incontro.
Lo sforzo fisico di resistere al sonno pur di soffrire, in piena solitudine, le pene di un amore desiderato e sconosciuto, vicino ed inesistente, per la mia, per la mia Gilda, bellissima, dolcissima, issima issima issima.
Ritornando a descrivere il percorso di avvicinamento alla meta “CAPIRE”, riprendo dalla “incipiente sensazione di completa immobilità” avvertita mentre stavo sbriciolando i bordi consunti del portone scavando nelle tane e tra le larve delle formiche”. Mi sono detto “Rilassati”.
Rifletti.
Alla sfida dei sentimenti, imponi la forza della ragione.
Alle sofferte rinunzie, continua ad opporre il riguardoso rispetto per scelte non tue, mai tue.
“Venti anni di solitudine sentimentale sferzati da ammalianti ricordi d’irripetibili emozioni trascinati come una croce incomprensibile, ingiusta, immeritata, immotivata, aspettano che tu compia altri passi, apra il portone, e segua i fluidi.
Per CAPIRE”.
Autocontrollo, tensione mentale, per una corporeità che avvertiva sempre maggiormente affievolite la capienza e la portata dei suoi terminali percettivi.
Di contro, il traino del mausoleo pieno di dubbi che mi ero trascinato dietro durante tanti anni, in quel luogo, in quel momento, davanti a quel portone, ha acquisito la struttura elementare di un guinzaglio.
E ad esso, nella parte terminale era aggrottala la scatolina porta oggetti in legno intarsiato a fuoco con le sagome di due cani ed un gatto che ho sempre conservata gelosamente, recuperandola quando era stipata tra i detriti alluvionali dei regali, salvandola dai roghi di vecchie cianfrusaglie appiccati per favorire nuove collocazioni d’insulsi modernismi, separandola dalla continue decimazioni perpetrate in danno di apparenti inutilità, ed inserendola nei numerosi traslochi per i miei trasferimenti abitativi.
Dimensioni ridotte – solo pochi centimetri per lato -, capienza minima, colore cartone bagnato, piccole cerniere deformate di latta brunita, il segno di una toppa in cui tempo addietro veniva inserita una chiave dai segmenti elementari, la parte superiore incisa in un bassorilievo con due cani di profilo sullo sfondo, muso contro muso, ed un gatto in primo piano di spalle con la testa rivolta verso l’alto.
Mi dicevo rilassati.
Con la luce che mi tagliava in due.
Da una parte, la schiena posta all’esterno dell’uscio coglieva il sole calante filtrato tra i residui di una nuvolaglia priva di pretese, dall’altra, il petto e le sporgenze del viso sguazzavano in un’ombra, un quasi buio perenne che imponeva, esso, alle mie palpebre di socchiudersi, alle mie iridi di rinchiudersi, alle mie fantasie di temere, al mio affetto di sovrapporre le doti alle forme.
Il volo gelatinoso ed ovattato di un odore senza definizione mi rendeva baco da seta in un bozzolo.
Avrebbero dovuto fermarmi prima che mettessi piede al di là del blocchetto di ottone sul quale una sporgenza ormai consunta e livellata da una sottile fanghiglia avrebbe potuto mostrare l’anno 1872 se solo fosse stato rimosso il velo di erbe selvatiche che lo ricopriva.
Ormai non avrei più ascoltato, anzi, udito, voci di richiamo. La raffinata attesa di CAPIRE era covata in me troppo tempo, rivivendo nel suo distillato fantastico, l’addio di Gilda, venti anni fa: una croce incomprensibile, ingiusta, immeritata, immotivata.
Deprimendomi ed entusiasmandomi nella ignota galassia dei suoi comportamenti e dei suoi sentimenti.
“Non devi più pensarmi”
“Impossibile, ti amo”
“Dimenticami.”
“Impossibile, mai”
“Voglio che non mi cerchi più”
“Perché?”
“Mai più”
“Fammi almeno CAPIRE”
“Addio”
Frasi e suoni, atmosfere movimenti stasi rimbalzi pianti pensieri carezze e sguardi e baci e strattoni e spinte e mani dolci ed incantate.
Tutto passato, tutto finito, tutto passato tutto finito con un addio incomprensibile, ingiusto, immeritato, immotivato, venti anni fa.
CAPIRE.
Magari, magari, magari una minima porzione, magari tutto. Magari con violenza, magari con dolore, liberandomi dalle notti finite su cuscini per terra con la testa una boa nel mare di scirocco.
“Un altro passo, apro il portone, seguo i fluidi”.
Ho inserito la chiave, quella di ferro avuta dal Notaio, nella toppa.
Ho ripetuto, inutilmente, tre volte il tentativo di far scattare la molla di apertura della serratura.
Alla quarta prova un leggero cedimento ha favorito il successivo sblocco del meccanismo di chiusura.
Ho mosso l’anta del portone solo di quel tanto utile al mio passaggio.
E sono entrato, richiudendo rapidamente.
Ero certo che le onde esistenziali, prigioniere della parva ampiezza spaziale nelle quali erano confinate, avrebbero potuto rivivere, per me, come durante la notte ignota della mia vita.
Nessuno avrebbe potuto dissuadermi dal credere che, così come è possibile catturare in qualunque ambiente onde magnetiche di suoni radiofonici, d’immagini televisive e di miliardi d’altri segnali provenienti da fonti emittenti quasi sempre sconosciute, allo stesso modo non sia possibile attraverso un distinto processo fisico – chimico – quantistico – ondulatorio – cosmico non importa, simile o dissimile dagli altri non importa, stabile, precario, materiale, non importa, ricostruire i flussi energetici originariamente espulsi con veemenza nello stesso luogo in cui tentiamo la loro intercettazione.
Volevo questo, ciò, nella stanza al primo piano dietro la finestra affacciata sul portone.
Come se bastassero le ombre, i fluidi, le onde elettromagnetiche a rappresentare sentimenti, immagini, speranze!
Via col vento senza Clark Gable e Rossella O’ Hara, Cabiria senza Giulietta Masina. Casablanca senza Humphrey Bogart, Stanlio ed Olio senza Stan Laurent and Oliver Hardy.
Per di più in un marasma generale entro il quale i movimenti delle comparse si mischiavano e si sovrapponevano alle azioni essenziali dei protagonisti.
Nonostante ogni logica opposta teoria, la mia attenzione nella maniacale ricostruzione degli unici ed irripetibili momenti che in quel luogo particolare avrebbero cambiato la mia esistenza, era attratta principalmente dalla ricerca di fluidi impalpabili, poco importandomi se fossero stati prodotti da azioni o da emozioni.
Solo ad essi era rivolta la mia ricerca.
È facile dire io sono.
Più difficile è affermare sono stato.
Ipocrita fingere di sapere io fui… dove i puntini di sospensione ritardano, insieme alla frase che dovrebbe riguardare l’avvenuta certezza, le tante e troppe etichette poste sulla nostra incosciente infanzia da persone che forse hanno voluto più bene a noi che a se stesse, ma che certo hanno articolato le parole secondo i loro amorosi punti di vista e le loro soggettive affettuose immaginazioni.
Io fui un bimbo bravo e sincero, mi è stato detto sempre così, ma chi ci crede?
Per Aurora – volume quinto – Così fu PARTE 1 CAPITOLO DODICESIMA
Dedica
La menopausa di mia sorella
Conversazione fra un totano ed una pantegana
CAPITOLO PRIMO
CAPITOLO SECONDO
CAPITOLO TERZO
CAPITOLO QUARTO
CAPITOLO QUINTO
CAPITOLO SESTO
Così fu
PARTE 1
CAPITOLO PRIMO
CAPITOLO SECONDO
CAPITOLO TERZO
CAPITOLO QUARTO
CAPITOLO QUINTO
CAPITOLO SESTO
CAPITOLO SETTIMO
CAPITOLO OTTAVO
CAPITOLO NONO
CAPITOLO DECIMO
CAPITOLO UNDICESIMO
CAPITOLO DODICESIMO
CAPITOLO TREDICESIMO
PARTE 2
CAPITOLO 1
CAPITOLO 2
Poesia sporca
Poesia sporca
Per Aurora – volume quinto – TESTO COMPLETO IN LETTURA LIBERA
ACQUISTA COM www.lulu.com
Per Aurora – volume quinto – Vetrina LULU
Per Aurora volume quinto di Bruno Mancini
seconda edizione
Version 5 | ID r99qmg
ISBN 9781471068423

Bruno Mancini
ISBN 9781471068423
Versione 4 | ID r99qmg
Creato: 31 ago 2022
Modificato: 31 ago 2022
Libro, 100 Pagine
Libro stampato: A5 (148 x 210 mm)
Standard Bianco e nero, 60# Bianco
Libro a copertina morbida
Lucido Copertina
Prezzo di vendita: EUR 14.00
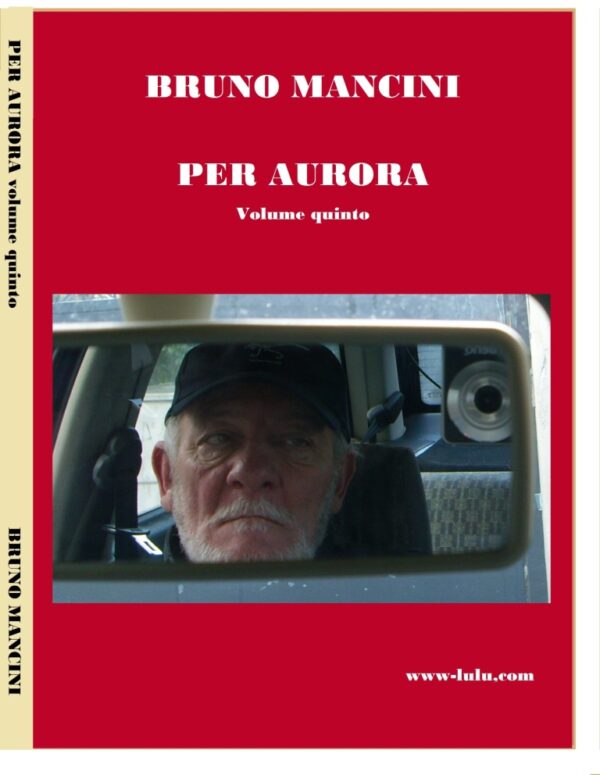
Titolo Per Aurora volume quinto
Sottotitolo Alla ricerca di belle storie d’amore
Collaboratori Bruno Mancini
ISBN 9781471068423
Marchio editoriale Lulu.com
Edizione Nuova edizione
Seconda edizione
Licenza Tutti i diritti riservati – Licenza di copyright standard
Titolare del copyright Bruno Mancini
Anno del copyright 2022
Per Aurora volume quinto
seconda edizione
Racconti
La menopausa di mia sorella
Così fu
Info: Bruno Mancini
Cell. 3914830355 tutti i giorni dalle 14 alle 23
emmegiischia@gmail.com
Views: 36

